Una frase del genere ti può salvare la vita
Ho da poco terminato la lettura dell’ultimo romanzo di Ben Lerner, Topeka School, pubblicato da Sellerio nella traduzione di Martina Testa.
Non ho ancora ben capito quali sono, ma le corde che tocca Lerner, almeno per quanto mi riguarda, non le tocca nessun altro autore contemporaneo.
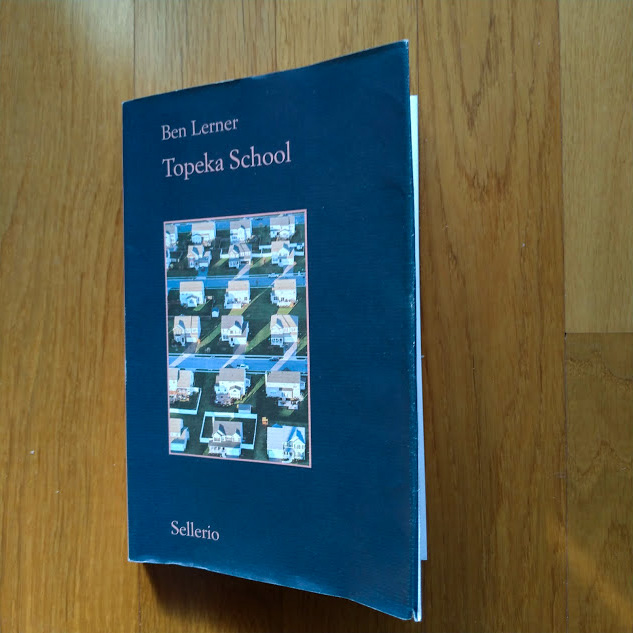
«Visitavo i pazienti giovani di giorno, i vecchi di sera. Dopo cena, Jane si sistemava nel suo studio e scriveva per un paio d’ore. (Dal suono della Seletric che arrivava da dietro la porta chiusa intuivo come stava venendo il libro: adesso che Jane aveva davanti la scadenza del parto – nel midollo di Adam già si stavano formando i globuli rossi; riusciva ad aprire gli occhi dentro di lei – sentivo una pioggia regolare di colpi sui tasti). Mentre lei lavorava io giravo per le stradine acciottolate di Potwin insieme a Klaus, che abitava a cinque minuti di distanza, un berlinese di un metro e novanta dall’eleganza incongrua, analista anziano presso la Fondazione, che si era trasferito a Topeka verso la fine degli anni Cinquanta da Zurigo, dove aveva lavorato con Jung. Da giovane Klaus era stato un promettente drammaturgo e aveva inoltre partecipato, come dilettante, a vari tornei di pugilato, finendo due volte col naso rotto prima dei diciannove anni, età alla quale aveva sposato Elke, nota in ambiente artistico per i suoi esperimenti di fotomontaggio. Avevano avuto un figlio, Fritz, nel 1937; nel 1940 Klaus aveva tentato di farli fuggire clandestinamente da Berlino, pagando perché venissero trasportati su un camion di generi alimentari fino in Olanda, dove li avrebbe raggiunti. Solo dopo la guerra era riuscito a ricostruire la storia di come erano stati traditi; due colpi di fucile che avrebbero riecheggiato per sempre nei boschi, nel suo orecchio interno. Quanto a lui, aveva trascorso la maggior parte della guerra nascosto in un pollaio, sognando di riunirsi alla famiglia (anche se nei suoi sogni, mi raccontò una volta, Fritz era una bambina), scrivendo pièce teatrali mentalmente per non impazzire, in quell’ambiente angusto che a un omone come lui provocava un dolore fisico continuo. Quando si facevano domande a Klaus su quegli anni – non erano in molti a fargliene – rispondeva con delle battute, specie sui polli, su quanto poco ci si potesse aspettare che contribuissero alla conversazione, o dessero buoni consigli di drammaturgia. I suoi genitori e tre sorelle erano morti ad Auschwitz. Solo noi polli siamo sopravvissuti, mi disse Klaus, svanito il sorriso, quando lo pressai sull’argomento.
Immaginateci illuminati per un attimo dai fari di un camion di passaggio mentre gira sulla rotonda di Greenwood Avenue: uno psicologo trentenne di New York che una volta si era fumato una sigaretta con Bob Dylan su Clinton Street e un occhialuto psicanalista europeo ultrasettantenne di un metro e novanta che era stato in rapporti cordiali con Einstein. Passeggiavamo in mezzo all’afa punitiva di agosto parlando dei miei stagisti, con il frinire delle cicale sullo sfondo. Da un lato Klaus, senz’altro l’unico uomo in tutta Topeka vestito di lino bianco, non riusciva a prendere sul serio questi ragazzini – coi loro frigoriferi pieni, l’aria condizionata e la televisione, la loro libertà dallo stigma o dalla violenza dello stato; cosa c’era di più ovvio del fatto che non sapessero cosa fosse la sofferenza, o del fatto che se soffrivano di qualcosa era proprio della mancanza di sofferenza, un tipo di patologia nervosa che nasceva dal troppo agio, dal troppo zucchero, una sorta di gotta esistenziale? E però, dall’altro lato, Klaus li prendeva anche estremamente sul serio: si sentono dire di continuo, dalla cultura in cui sono immersi, anche se “cultura” non è certo il termine adatto, diceva Klaus, tamponandosi la fronte con un fazzoletto fatto dello stesso lino del completo, che sono individui, individui anche belli tosti, ma in realtà sono svuotati, isolati, uomini di massa senza una massa, anche se non sono uomini, ovviamente, ma ragazzi, eterni ragazzi, Peter Pan, uomini-bambini, perché l’America è un’adolescenza senza fine, ragazzi senza Dio da una parte o senza un leader carismatico dall’altra; non hanno neanche un ladre – il presidente Carter! – da uccidere o un padre che gli dica di uccidere gli ebrei; non ce li hanno gli ebrei; subiscono una spinta libidica alla resa di massa senza avere niente a cui arrendersi; non credono nemmeno nei soldi o nella scienza, o comunque la loro fede in quel senso è limitata; il loro paese ha combattuto e perso l’ultima vera guerra; per farla breve: sono ipernutriti; per farla breve: muoiono di fame. A questi ragazzi, diceva Klaus, servono un po’ di calci nel sedere e di fatica fisica: questi ragazzi, diceva anche, stanno vivendo una profonda regressione arcaica. I ragazzi sono fatti così, li liquidava Klaus, e i ragazzi viziati sono così, e però poi, tenendosi il fazzoletto sulla nuca: l’abisso della mancanza di fede, quel vuoto, non lo si può riempire di roba (a Klaus piaceva molto la parola inglese stuff, che a me suonava tedesca, ma non lo era: dal greco stuphein, “mettere insieme”), e la violenza periodicamente tornerà sempre – come tornano le cicale. E poi ci arriva una sventagliata di schizzi dall’irrigatore girevole di un vicino, il piacevole shock dell’acqua fredda sugli stinchi.
Se gli dicevo: Klaus, tu sostieni che il problema è che se la passano troppo bene, ma dici anche che il passarsela troppo bene fa troppo male; dici che è sempre stato così, ma anche che questo vuoto al centro della vita privilegiata è il sintomo dello specifico declino dell’impero, ecco che Klaus rispondeva tirando fuori la sua solita citazione di Niels Bohr, la frase che citava sempre quando sembrava che si contraddicesse, una frase verso cui la sua conversazione inesorabilmente tendeva, e che lui amava così tanto da fermarsi e restare immobile, sorridente, nel pronunciarla: “Il contrario di una verità”, recitava, “è una menzogna; ma il contrario di una verità profonda” pausa enfatica, rumore di irrigatori, insetti, tosaerba, assenza percepita di rumori cittadini, Kenny Rogers da una macchina di passaggio “può darsi che sia un’altra verità profonda”. O è agosto, o non è agosto (Klaus si toglie i suoi anacronistici occhiali, lenti rotonde, si asciuga il viso, se li rimette, riprende a camminare); se io affermo che è agosto quando non lo è: pura menzogna; ma se dico che la vita è dolore, questo è vero, a livello profondo; così come è vero che la vita è gioia; più è profonda l’affermazione, più è rovesciabile; le verità profonde sono sedimentate nella sintassi, i termini si possono ribaltare, proprio come non c’è nessun principio di contraddizione, nessuna legge del terzo escluso, a governare l’inconscio. Poi, serio per un attimo, Klaus mi toccava la mano: Una frase del genere ti può salvare la vita.»
