22 febbraio 1980 — Valerio Verbano
Quarant’anni fa a Roma, in via Monte Bianco 114, tre uomini (a oggi non ancora identificati) uccidevano Valerio Verbano, diciannove anni, militante dell’autonomia operaia romana.

Nonostante all’epoca i delitti politici fossero all’ordine del giorno, l’omicidio Verbano desta molta impressione, sia perché la vittima era molto conosciuta nell’ambiente della sinistra radicale, sia, soprattutto, per la dinamica dell’omicidio. Valerio non muore in seguito a un agguato in mezzo alla strada o a uno scontro di piazza tra opposte fazioni politiche; chi lo uccide sceglie di farlo in un modo che non si era mai visto fino ad allora, o quasi.
Intorno all’ora di pranzo del 22 febbraio 1980 i tre aggressori suonano alla porta di casa di Valerio, che vive insieme alla mamma Carla, infermiera, e al papà Sardo, dipendente del ministero dell’Interno, in un appartamento al quarto piano di una palazzina nel quartiere Monte Sacro. In quel momento Valerio è ancora a scuola, sarebbe rientrato come sempre verso le 14. È Carla, la mamma, che va ad aprire. Ed è sempre lei a raccontare quello che succede di lì a pochi istanti, nel libro Sia folgorante la fine, scritto con il giornalista Alessandro Capponi e pubblicato da Rizzoli nel 2010:
«Chi è?»
Non è che apro subito. Domando sempre chi è, non apro mai la porta così, senza chiedere. Anche se poi, in effetti, non è che serva un granché, chiedere.
Risponde un ragazzo: «Siamo amici di Valerio».
«Ma Valerio è a scuola» dico io.
«Signora, ci faccia entrare, siamo stanchi che abbiamo camminato tanto, dobbiamo chiedere una cosa a Valerio. Lo possiamo aspettare in casa, siamo amici».
Spingo in basso la maniglia come ho fatto migliaia di altre volte, apro, sto per dire prego, accomodatevi.
L’assassino si abbassa il passamontagna, mi colpisce, mi fa girare, mi spinge contro il muro e mi mette una mano sulla bocca. Ne vedo tre, ne sento tre, ma non so quanti sono, cosa vogliono. Penso a una rapina, a dei pazzi criminali, a niente, a come liberarmi dalla presa.
Sento la voce di mio marito, ancora in camera da letto a cambiarsi d’abito: «Carla, chi era alla porta?».
Chi era, dice. Ma questi tre sono qui adesso, e i due che non mi sono addosso vanno verso la voce. In camera da letto. Da Sardo.
Non so se sono armati, ma anche se non lo fossero Sardo cosa può fare? «Aiuto»provo a urlare, ma la mano sulla bocca me lo impedisce. Viene fuori solo un lamento, basso basso.
Sono schiacciata contro il muro e non posso muovermi, cerco di dimenarmi ma non riesco a fare niente, non riesco neanche a staccarmi da questo muro.
All’improvviso sento qualcosa che cade e rimbalza. Poi fracasso di oggetti colpiti, di un corpo contro cose. Immagino Sardo nella mia stessa posizione, con la faccia premuta contro una parete. Invece in camera da letto non è così che sta andando.
Dopo aver immobilizzato i genitori di Valerio, i tre uomini si dividono: uno rimane con loro in camera, per sorvegliarli, mentre gli altri due si spostano in salotto ad attendere il bersaglio.
Quando la porta di casa si apre la colluttazione è immediata: Valerio — che sa difendersi poiché pratica da anni judo e karate — riesce addirittura a disarmare uno dei tre aggressori, cerca di scappare dal terrazzo ma viene raggiunto da un colpo di pistola alla schiena che lo fa cadere riverso sul divano. Morirà di lì a pochi minuti, mentre un’ambulanza lo sta trasportando al Policlinico.
Prima che i vicini, allertati dal trambusto e dallo sparo, abbiano il tempo di accorrere, i tre uomini si allontanano indisturbati, ma lasciando dietro di sé, nell’appartamento dei Verbano, tracce della loro presenza non proprio insignificanti: l’arma del delitto, per esempio — una Beretta 7,65, calibro 38, munita di silenziatore, che risulterà essere stata smarrita un anno prima da un agente della polizia, Bruno Raffani, in circostanze a dir poco grottesche; il passamontagna indossato da uno dei tre aggressori e probabilmente perso durante la colluttazione; un altro berretto di lana; un paio di occhiali da sole (sui quali bisognerà tornare); ; un bottone e uno zucchetto di lana; e un guinzaglio per cani, con un collare in cuoio legato a una catena d’acciaio.
Nessuno, però, nota i tre uomini quando escono dalla palazzina di via Monte Bianco, fatta eccezione per il signor Gino De Angelis, un inquilino dello stabile che abita proprio sopra ai Verbano e che in quel momento, dopo aver parcheggiato l’auto, sta entrando nel portone. Poche ore dopo De Angelis rilascia agli inquirenti una testimonianza scritta nella quale dichiara di aver riconosciuto «tre individui sui vent’anni che stavano uscendo con passo piuttosto svelto» — uno longilineo, mentre gli altri due, rispetto al primo, un po’ più paffuti, ma non grassi. E soprattutto che «alcuni giorni addietro, non ricordo con esattezza quando, tra le ore 13 e le 14, notai quattro giovani, tra cui il Verbano Valerio, in via Monte Bianco, nei pressi del Circolo Enal: li vidi che parlavano tra di loro. Mi sembra che i tre giovani incontrati oggi siano gli stessi».
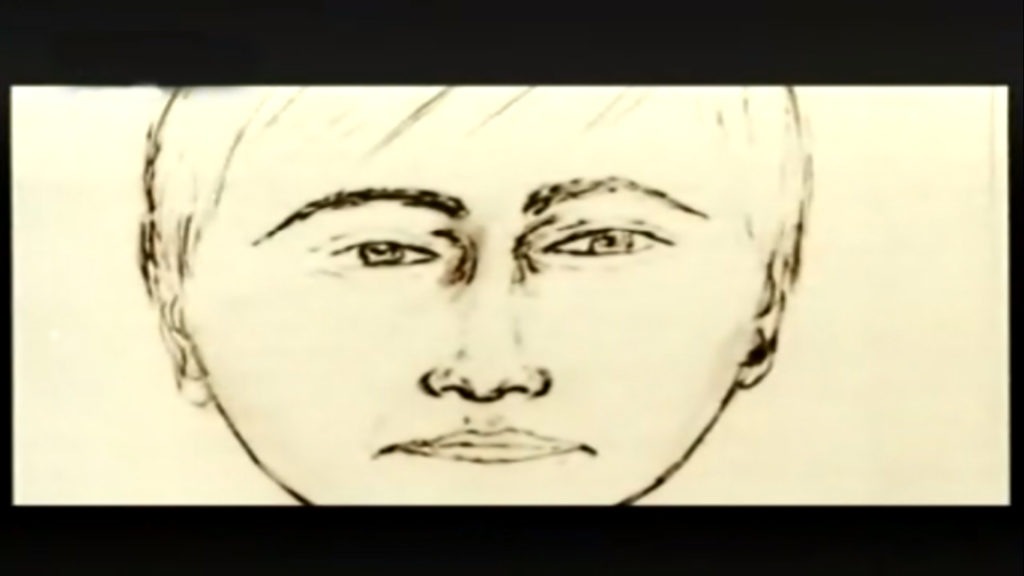

Quella di De Angelis sarà l’unica testimonianza oculare rilevante sull’omicidio Verbano, intorno al quale, negli anni successivi, emergeranno pochissimi elementi attendibili. Tanto che nel 1989 — dopo nove anni di indagini scanditi da una surreale successione di rivendicazioni contraddittorie, rivelazioni di pentiti più o meno attendibili, ipotesi investigative, errori e omissioni — verrà chiesta l’archiviazione del procedimento, anche a causa dell’«assoluta ermeticità che ha caratterizzato la condotta precedente e successiva dei responsabili». E contestualmente alla conclusione delle indagini verrà anche ordinata la distruzione di gran parte degli elementi di prova raccolti negli anni dagli investigatori, tanto che di tutti gli oggetti ritrovati nell’appartamento dei Verbano e custoditi per anni nell’ufficio Corpi di reato del tribunale di Roma si salveranno solo il bottone e gli occhiali da sole (e la Beretta 7,65, certo, anche se di quella pistola si perderanno le tracce per molto tempo). Tutto il resto, distrutto o scomparso.
L’unica certezza a cui pervengono gli investigatori è che si sia trattato di un omicidio politico maturato negli ambienti dell’estrema destra romana, da attribuire forse ai Nuclei armati rivoluzionari o forse a Terza posizione, e forse motivato dal desiderio di vendetta per quella rissa in piazza Annibaliano di alcuni mesi prima, durante la quale Valerio aveva ferito con una coltellata alla schiena Nanni De Angelis, uomo di punta di Terza Posizione, o forse da quell’attività di controinformazione che Valerio conduceva da molti mesi proprio intorno al neofascismo della capitale. Forse serve fare un passo indietro, per capire meglio.
Il 20 aprile 1979 Valerio, all’epoca appena maggiorenne, viene sorpreso dalle forze dell’ordine mentre, insieme a quattro compagni, confeziona ordigni rudimentali all’interno di un casolare abbandonato nella periferia romana, seguendo le istruzioni contenuto nel volume Il sangue dei leoni di Édouard-Marcel Sumbu, una sorta di manuale tecnico-militare di guerriglia pubblicato da Feltrinelli nel 1969.
La successiva perquisizione nell’appartamento di via Monte Bianco conduce al ritrovamento nella stanza di Valerio di un’arma da fuoco con la matricola abrasa, e di un voluminoso dossier sequestrato dalle autorità e ricomparso, in seguito a un’esplicita richiesta dei genitori, pochi giorni dopo la morte di Valerio; non nella sua versione originale, però, misteriosamente scomparsa, bensì in una copia fotostatica e per di più notevolmente ridotta nella foliazione.
Il dossier è una sorta di schedario contenente nome, domicilio, professione, appartenenza politica e abituali luoghi di frequentazione/ritrovo di un nutrito numero di neofascisti, noti e meno noti, con corredo di foto (spesso scattate dallo stesso Valerio, grande appassionato di fotografia), ritagli di giornale e cronologia degli eventi; un organigramma dell’eversione nera romana, insomma, che Valerio aveva iniziato a comporre due anni prima, ancora sedicenne.
Per quegli ordigni confezionati nel casolare e per quella pistola ritrovata nella sua stanza, Valerio, unico maggiorenne del gruppo, viene condannato a sette mesi di carcere, che sconta a Regina Coeli. Pochi mesi dopo essere uscito di prigione verrà ucciso nel salotto di casa. Tutto abbastanza normale nell’Italia di fine anni Settanta e inizio anni Ottanta, ma al tempo stesso tutto molto anomalo. Come anomala è la vicenda di quel dossier, raccontata bene da Marco Capoccetti Boccia in Valerio Verbano – Una ferita ancora aperta, libro-inchiesta pubblicato nel 2011 da Castelvecchi e ristampato in una nuova edizione proprio in questi giorni dalla casa editrice Lorusso.
Nel novembre del 1984 la Corte d’Appello che aveva giudicato Valerio nel 1979 ordina la distruzione del dossier, di cui non si sa più nulla fino al 2011 quando, come vedremo più avanti, il caso Verbano verrà riaperto e il fascicolo, in teoria andato distrutto, ricomparirà nelle mani dei carabinieri.
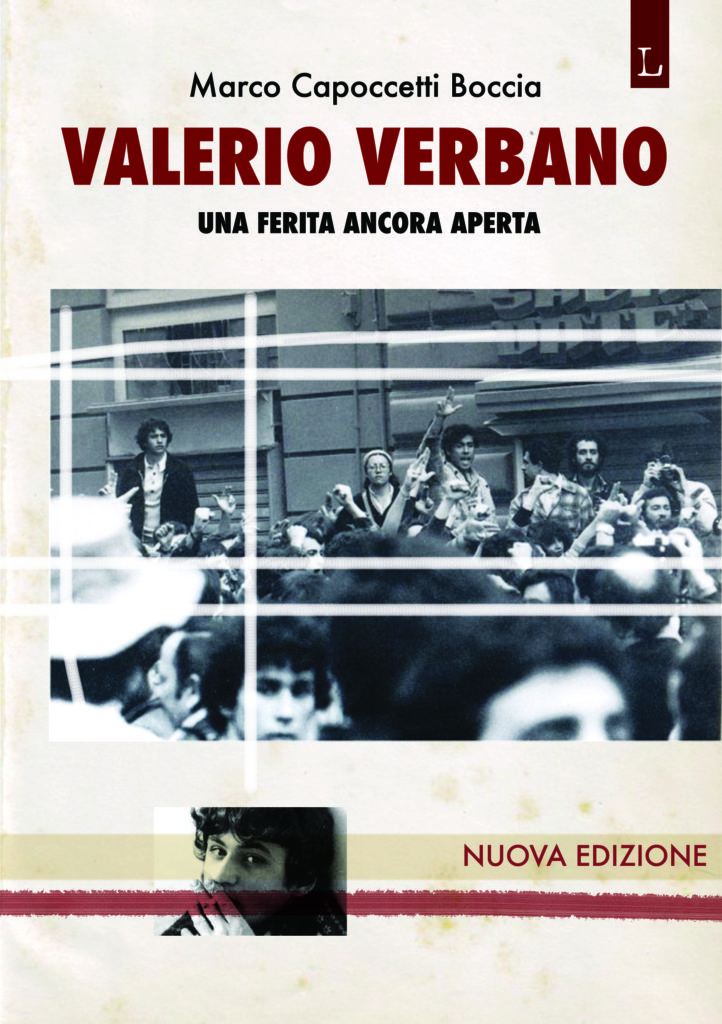
Mentre provo a fare ordine in questa matassa di stranezze, cerco anche di ricordare la prima volta, la prima di tante, che sono andato in via Monte Bianco 114, ma non ci riesco, è passato troppo tempo. Così apro il mio piccolo archivio di foto romane e la nebbia pian piano si dirada.
Marzo 2009. Probabilmente era una domenica mattina, perché non c’è niente di più bello che girare per Roma in bicicletta la domenica mattina. Devo essere partito da via della Casilina Vecchia, dove abitavo all’epoca, proprio di fronte all’acquedotto Felice, per poi sfiorare San Lorenzo e il Verano, dove probabilmente sarò sceso dalla bici per fotografare quella scritta sul muro del cimitero che mi ha sempre fatto molto ridere.

Per evitare guai lungo la circonvallazione interna e la tangenziale est, avrò allungato un po’ il tragitto, passando davanti alla Sapienza e attraversando i quartieri Trieste e Africano, per poi imboccare via delle Valli che, dopo aver attraversato l’Aniene, sbuca su piazza Conca d’Oro. E da lì su per viale Tirreno e viale Pantelleria, fino a quella piccola traversa ribattezza con il nome della cima più alta delle Alpi.
Solo in questa zona della città, tra Monte Sacro e Talenti, nel biennio 1978-79 ci sono stati 42 attentati dinamitardi e 87 aggressioni di matrice politica. Qui, tra viale Jonio e via Monte Rocchetta, quattro mesi dopo l’omicidio Verbano, è stato giustiziato il giudice Mario Amato, mentre aspettava l’autobus pochi minuti dopo essere uscito dalla propria casa in via Gran Paradiso, a dieci minuti di camminata da via Monte Bianco. Amato venne freddato da due uomini, Gilberto Cavallini e Luigi Ciavardini, di quella sigla della galassia nera, i Nuclei armati rivoluzionari (Nar), sui quali stava indagando dopo aver ereditato l’inchiesta sull’eversione neofascista dal collega Vittorio Occorsio, a sua volta assassinato da un altro camerata, Pierluigi Concutelli, il 10 luglio 1976.
«Quand’è morto Mario Amato io non avevo ancora capito che lui era la mia unica possibilità di trovare l’assassinio di mio figlio» dirà Carla Verbano. Perché dopo la morte di Occorsio, Amato è stato il primo magistrato della procura di Roma a mettere insieme i tasselli dell’eversione nera: non si limitava a esaminare i singoli episodi, ma cercava un quadro d’insieme. Al giudice Amato il dossier di Valerio Verbano sarebbe piaciuto.

Arrivati in via Monte Bianco, la palazzina dei Verbano si nota subito perché alla sua base — a pochi metri dalla targa dedicata a Valerio che diverse volte è stata incendiata o imbrattata con svastiche e celtiche — una grande scritta in vernice rossa dice quello che non è un semplice slogan, ma un dato di fatto. Almeno a giudicare dalle tante iniziative che a quarant’anni di distanza ricordano la figura di Valerio, prima tra tutte l’attività della palestra popolare intitolata a suo nome, inaugurata nel 2018 nel cuore del quartiere Tufello e che quella domenica di marzo del 2009 ho raggiunto dopo un’altra decina di minuti di pedalata. Non ho mai avuto l’occasione di visitarla all’interno (quella mattina era chiusa) ma basta dare un’occhiata alle foto e alle notizie che girano in rete per farsi un’idea di quale sia la sua vitalità e presenza nel quartiere.


Il 28 ottobre 2011 un articolo della Repubblica firmato da Martina di Berardino intitolava: Omicidio Verbano: ecco il Dna del killer. Il pm, test sui due sospettati. Nel febbraio dello stesso anno, la procura di Roma aveva confermato la riapertura delle indagini, affidate al procuratore aggiunto Pietro Saviotti e al pm Erminio Amelio, e la notizia di una svolta — resa possibile dai «progressi della scienza forense» grazie ai quali «è stato isolato un profilo di Dna dalle stanghette e dal nasello degli occhiali ritrovati in casa Verbano» — aveva destato più di una speranza. Anche, probabilmente, in Carla Verbano, che però sarebbe morta di lì a pochi mesi, il 5 giugno 2012, senza mai conoscere la vera identità degli assassini del suo unico figlio.
A oggi, infatti, quelle attese sono andate disilluse, e lo scorso settembre è divenuta ufficiale l’ennesima richiesta di archiviazione per il fascicolo di indagine relativo all’omicidio di Valerio Verbano.
Quella domenica di marzo del 2009, dopo aver visitato il Tufello ricordo di essermi perso da qualche parte in via delle Vigne Nuove, un posto che non avevo mai visto prima e che pure mi diceva qualcosa. Sono salito su una collinetta d’erba e terriccio che dava su un grande discount e da lì ho fotografato le torri di un gigantesco complesso di edilizia popolare, come tanti se ne vedono girando a caso nella periferia romana, ripensando a una delle tante storie a margine del caso Verbano, probabilmente quella che mi ha sempre colpito più delle altre e di cui avevo letto pochi mesi prima sulle pagine di Cuori neri, il libro di Luca Telese che ricostruisce «la storia di 21 vittime dimenticate degli anni di piombo».


Pochi giorni dopo quel 22 febbraio 1980, Sardo e Carla telefonano a casa del neofascista Nanni De Angelis, il giovane di Terza posizione che era stato accoltellato da Valerio nello scontro di piazza Annibaliano, e gli propongono un incontro privato, nel loro appartamento di via Monte Bianco. Vogliono capire se lui c’entra qualcosa o può dire qualcosa; vogliono chiedere a Nazareno, detto Nanni, se davvero c’è quella stupida rissa all’origine di tutto, se davvero è stata solo una vendetta; e magari Carla, vendendo il ragazzo, potrebbe riconoscerlo.
Nanni, contro il parere della sua stessa famiglia, accetta l’incontro.
Ci sono i compagni di Valerio sotto il portone, ma c’è anche suo padre. Nanni entra, salgono su, parlano per quasi un’ora, il tempo vola. Gli aggressori di Valerio il giorno dell’omicidio erano camuffati, ma nessuno potrebbe dimenticare una corporatura come quella di Nanni, confonderla con quella di un altro. La madre e il padre di Valerio quel giorno erano lì, capiscono che non può essere De Angelis uno degli assassini. Lui ammira il lutto asciutto e pieno di dignità di quei genitori, la cortesia con cui lo ascoltano, dice loro di come avrebbe voluto che quell’incontro non fosse dovuto avvenire nel mezzo di una guerra. Guardandoli negli occhi dice quello che doveva dire: «Non sono stato io. Se fossi stato io, adesso non sarei qui». […] Quando il colloquio è finito il padre di Valerio si avvicina al telefono, chiama un taxi. Poi accompagna Nanni fino al portone, lo scorta fra due ali di sguardi stupiti, senza che nessuno, fra gli extraparlamentari di sinistra, tenti nemmeno di violare quel tacito accordo, senza che nessuno muova un dito. Il padre di Valerio mette Nanni sul taxi e resta lì, in mezzo alla strada, finché non è sicuro che il ragazzo sia lontano, in salvo.
